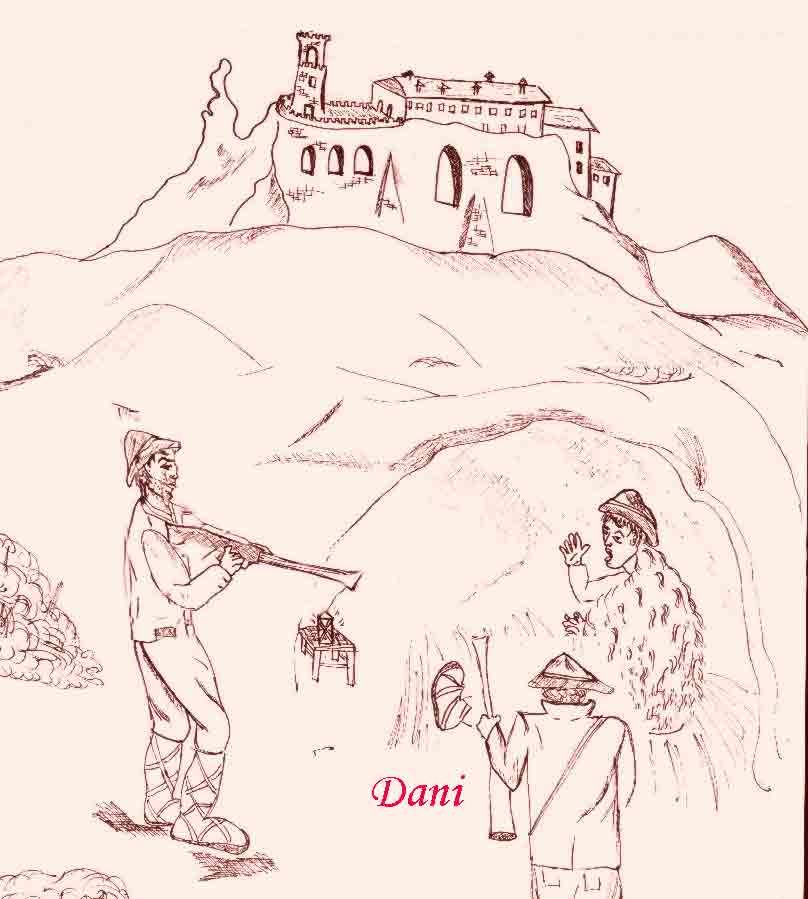|
|
||||
|
In questa pagina troverai racconti, motti arguti, storie, leggende, insomma un condensato della cultura popolare caccurese. Molti testi fanno riferimento alla tradizione orale, altri sono frutto della mia fantasia che, comunque, fa tesoro dei racconti dei nostri nonni. La pagina verrà aggiornata spesso. |
||||
|
La fine del brigante Storie
di braccianti e di soprastanti |
La
fine del brigante Gasparone
|
|
I verri maleritti ‘Ntra
la grancia ‘e Bonuligno Ma
lu populu sarbaggiu Pugni,
cauci e palate
|
I
verri maledetti Nella
tenuta di Buonolegno Ma
a Palermo, in Sicilia Tutte
quelle ricche terre Ma
il popolo fiero |
Torna all'inizio
Storie di braccianti e di soprastanti
La
storia dei contadini e dei braccianti caccuresi è, come tutte le
storie della povera gente, una storia di sacrifici, sofferenza,
sfruttamento, povertà, una storia di uomini angariati dalla sorte e
dai loro simili che li facevano ammazzare di fatica per un misero
salario. A quei tempi si lavorava da “stilla a stilla”, dall’alba
al tramonto per una ricotta o due litri di olio o un pugno di grano.
A
soprintendere l lavoro di questa povera umanità vi era quasi sempre
il soprastante del barone, il caporale, avrebbe detto il
grande Totò, che cercava, con tutti i mezzi, di ottenere il massimo
da quest’uomini macilenti e ossuti.
Uno
di questi sorveglianti aveva escogitato una trovata perversa che
triplica, quadruplicava o quintuplicava l’impegno
la resa dei poveri braccianti.
Al
mattino presto, dopo un’abbondante colazione, il fedele braccio
destro del barone si faceva trovare nel luogo di raduno dei
braccianti che, in fila indiana, si avviano ai campi. Si portava in
coda alla fila e……….
Quello del fico!

La
storia dei contadini e dei braccianti caccuresi è, come tutte le
storie della povera gente, una storia di sacrifici, sofferenza,
sfruttamento, povertà, una storia di uomini angariati dalla sorte e
dai loro simili che li facevano ammazzare di fatica per un misero
salario. A quei tempi si lavorava da “stilla a stilla”, dall’alba
al tramonto per una ricotta o due litri di olio o un pugno di grano.
Si
accostava con fare furtivo ad uno di quei poveri cristi e gli
allungava, facendo attenzione a non farsi scorgere dagli altri
lavoratori, uno o due fichi secchi con le mandorle. “Tieni, gli
diceva, sei un bravo giovane tu! Meriti davvero questa attenzione,
mangia che ti togli un po’ di fame. Ma ti raccomando, non dirlo ai
tuoi compagni. E’ un’attenzione che mi sento di fare solo a te,
non vorrei che tutti mi piombassero addosso chiedendomi fichi. Mica
ne ho la dispensa piena io!” Poi, mentre il povero lavoratore
ringraziava commosso, si staccava da lui e ripeteva la stessa
operazione con tutti gli uomini della fila, sempre badando di non
farsi vedere e non farsi sentire dagli altri.
Poi si portava in testa al gruppo ed
accelerava l’andatura per guadagnare qualche minuto di lavoro.
Giuseppe Marino
"Caccuri
e Cerenzia, i paisi e ra ciotia"
(Caccuri e Cerenzia i paesi della dabbenaggine)

Ruderi della vecchia Cerenzia (Acheronthìa)
"Caccuri e
Cerenzia, i paisi 'e ra ciotia!" La disgraziata rima ha
condizionato e condiziona ancora la vita dei due paesi limitrofi
favorendo la nascita di una lunga serie di aneddoti in verità
gustosi, sugli abitanti e sulle relazioni tra i due centri. I Caccuresi
non perdono l'occasione per ironizzare sui Cerentinesi e questi
ricambiano di gusto: Si racconta che nel 1848, quando i Cerentinesi
abbandonarono l'antica Acheronthia per trasferirsi nel nuovo centro che
era sorto a Paparotto, riuscirono a stento a costruire la chiesa, ma
non ebbero la possibilità di comprare una campana che potesse scandire
lo scorrere del tempo e perdevano facilmente il conto delle ore. Per
fortuna nella vicina Caccuri vi era una grande campana i cui rintocchi
si udivano distintamente anche a Cerenzia e così i Cerentinesi
pensarono di aver risolto il problema. Quando i caccuresi vennero a
sapere di questa, diciamo così appropriazione indebita di rintocchi,
si arrabbiarono moltissimo e, per prima cosa, decisero di innalzare una
siepe di filo spinato e frasche lungo il confine tra i due comuni per
impedire al suono delle campane di raggiungere Cerenzia. Tutta la
popolazione si portò sul cantiere e, lavorando alacremente, in men che
non si dica, la siepe fu eretta. Poi i Caccuresi decisero di dare una
lezione ai vicini scrocconi portandosi via la loro chiesa. Una
cinquantina di ragazzi caccuresi scelti tra i più robusti partirono
alla volta della cittadina rivale per caricarsi la chiesa sulle spalle
e trasferirla a Caccuri. La notizia si sparse in un baleno seminando il
panico tra i Cerentinesi. Fu immediatamente emanato un bando che
ingiungeva a tutte le donne gravide di Cerenzia di sedersi sul sagrato
della chiesa in modo da aumentarne sensibilmente il peso e far fallire
l'impresa degli odiati vicini. Così fu e i forzuti caccuresi dovettero
rinunciare alla vendetta. I Cerentinesi, felici per lo scampato
pericolo, decisero di vendicarsi giocando d'astuzia. vedendo brillare
nel cielo caccurese una splendida luna, invidiosi di tanta fortuna,
decisero di impadronirsene furtivamente. Si partirono da Cerenzia,
scavalcarono la siepe e giunsero in poco tempo a Caccuri. Si fermarono
alla fontana di Canalaci per bere un sorso d'acqua e videro nel
lavatoio l'astro d'argento. Rubarono in una stalla vicina un truogolo,
lo immersero nel lavatoio riempiendolo d'acqua con dentro la luna e,
caricatoselo in spalla, raggiunsero le periferie di Cerenzia. La luna
era lì, abbagliante nel truogolo. Lo deposero delicatamente a terra e
corsero in paese a cercare una scala per appendere la luna alla quercia
più alta. Tornarono con la scala al truogolo, ma la luna era sparita.
Rimasero sgomenti e volsero lo sguardo verso Caccuri. Qualche attimo
dopo la luna sbucò da dietro una nuvola più splendente che mai nel
cielo. "Maledetti Caccuresi!! esclamarono furiosi, se la sono
ripresa mentre cercavamo la scala."
Nel proporre questa amena storiella e' d'obbligo mettere in evidenza che i due paesi interessati sono e sono stati e sono tra i più illustri, civili ed evoluti dell'intera Calabria. Tutto ebbe origine, evidentemente, da quell'infelice rima che, in ogni caso, ha favorito il fiorire di favole degne della migliore letteratura.
Giuseppe Marino
Torna all'inizio
La leggenda del tesoro di Sant'Andrea
I n una notte buia e tempestosa
di qualche secolo fa una
feroce banda di briganti era adunata sotto una grande quercia a Sant’Andrea,
a due passi dal vecchio convento.
I lampi squarciavano le tenebre creando riflessi rossastri sulle
facce spaventose dei terribili ceffi. L’acqua cadeva a scrosci ed il
vento mugolava sinistramente tra gli alberi. Era la nottata ideale per
nascondere un tesoro grondante sangue, frutto di ruberie, assassinii,
saccheggi.
Il
capo dei masnadieri fece scavare una buca molto profonda nella quale
vennero occultati con cura monili, monete d’oro, pietre
preziose custoditi all’interno di un forziere. Poi i bricconi
cancellarono accuratamente ogni traccia del loro lavoro e giurarono
solennemente che mai, nessuno di loro, per nessun motivo, avrebbe rivelato il nascondiglio del bottino. Infine una megera, moglie di uno
dei fuorilegge, mentre i lampi diventano sempre più spaventosi e l’atmosfera
del luogo diveniva sempre più cupa e sinistra, pronunciò una formula
magica e stabilì un sortilegio a protezione del tesoro.
Qualche
settimana dopo la terribile notte, la feroce comitiva venne sgominata
in un conflitto a fuoco con i gendarmi. Nessuno si salvò,
nemmeno le donne, nemmeno la fattucchiera. Qualcuno, però, prima di
morire, si era, evidentemente, lasciato sfuggire qualcosa per cui si
diffuse la voce che per impadronirsi delle inestimabili ricchezze
custodite sotto la quercia, alla base del grande muro,
bisognava scannarvi nei pressi una donna incinta e somministrare
l’eucarestia ad un gallo.
La
notizia si tramandò di generazione in generazione, però, da
allora, nessuno è riuscito a mettere le mani sul malloppo, non tanto
perché non vi sia uno scellerato capace di sgozzare una donna incinta,
quanto per la difficoltà di reperire un pennuto disposto a confessarsi
e comunicarsi. E così il tesoro è ancora lì, da quasi due secoli, in
attesa di uno sciagurato capace di una simile impresa e di un “re del
pollaio” che voglia salvarsi l’anima.
Non
c’è più, invece, il vecchio muro abbattuto negli anni ’80 per
costruirvi un campo di tennis all’interno del parco comunale.
Il capo dei masnadieri fece scavare una buca molto profonda nella quale vennero occultati con cura monili, monete d’oro, pietre preziose custoditi all’interno di un forziere. Poi i bricconi cancellarono accuratamente ogni traccia del loro lavoro e giurarono solennemente che mai, nessuno di loro, per nessun motivo, avrebbe rivelato il nascondiglio del bottino. Infine una megera, moglie di uno dei fuorilegge, mentre i lampi diventano sempre più spaventosi e l’atmosfera del luogo diveniva sempre più cupa e sinistra, pronunciò una formula magica e stabilì un sortilegio a protezione del tesoro.
Qualche settimana dopo la terribile notte, la feroce comitiva venne sgominata in un conflitto a fuoco con i gendarmi. Nessuno si salvò, nemmeno le donne, nemmeno la fattucchiera. Qualcuno, però, prima di morire, si era, evidentemente, lasciato sfuggire qualcosa per cui si diffuse la voce che per impadronirsi delle inestimabili ricchezze custodite sotto la quercia, alla base del grande muro, bisognava scannarvi nei pressi una donna incinta e somministrare l’eucarestia ad un gallo.
La notizia si tramandò di generazione in generazione, però, da allora, nessuno è riuscito a mettere le mani sul malloppo, non tanto perché non vi sia uno scellerato capace di sgozzare una donna incinta, quanto per la difficoltà di reperire un pennuto disposto a confessarsi e comunicarsi. E così il tesoro è ancora lì, da quasi due secoli, in attesa di uno sciagurato capace di una simile impresa e di un “re del pollaio” che voglia salvarsi l’anima.
Non c’è più, invece, il vecchio muro abbattuto negli anni ’80 per costruirvi un campo di tennis all’interno del parco comunale.
Torna all'inizio
Il terribile mostro di Trabese
(da un'antica storiella locale rielaborata da Giuseppe Marino)
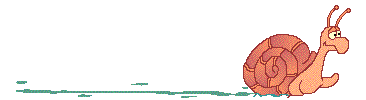
All’improvviso
un urlo terrificante ruppe la calma serena che regnava nell’aprica
valle di Trabbese, un lembo di terra dell’agro di Cerenzia, nei
pressi dei ruderi della vecchia cittadina di Acerenthia, a circa due
miglia da Caccuri. “Aiuto, aiutoooo! Accorrete, accorrete gente!
Venite con schioppi, coltelli, pugnali, bastoni, presto, accorrete!”
Il giovane contadino cerentinese, terrorizzato, ansante e con la
schiuma alla bocca, sbucò all’improvviso da una macchia di
lentischio, proprio mentre si trovava a passare da quelle parti un
caccurese che, col suo asino, tornava dalla vicina Verzino dove s’era
recato a vendere un tomolo di fagioli.
Torna
all'inizio
I cagnusi di Caccuri
La
leggenda del mostro della valle di Trabbese è senz’altro una
invenzione di qualche buontempone caccurese del secolo scorso. Ma i
simpatici amici cerentinesi non accettavano passivamente frizzi e
lazzi dei vicini burloni e, a loro volta, inventavano delle altre
storie non meno spassose e salaci ai danni dei Caccuresi. Pare
che a quei tempi, per una carenza di iodio nell’acqua di Caccuri e
nell’alimentazione in generale, si verificasse nella popolazione del
paese vicino, un’alterazione della funzione tiroidea con l’insorgere
di gozzi a volta anche molto consistenti. Ovviamente il disturbo
affiggeva anche le ragazze caccuresi che, però, a detta dei
Cerentinesi, esibivano questo non propriamente estetico accessorio con
orgoglio “elevandolo addirittura a titolo dotale” Il gozzo,
insomma, insieme al corredo, era, per le giovani caccuresi, anche una
sorta di dote. E così, quando una di loro tardava a trovare
marito, pare si rivolgesse al patrono, San Rocco, con questa preghiera
propiziatoria.
Santu Roccu mio benigno San Rocco mio, benigno
Tu lu sai pecchì ce vegnu
Tu sai perché vengo ad implorarti.
Tanta brutta nun ce signu,
Tanto brutta poi non sono,
Nu pocù ‘e cagnu puru ‘u tegnu.
E possiedo anche un po’ di gozzo.
Questa simpatica storiella che mette un po’ in ridicolo le bellissime
ragazze caccuresi è stata ripresa dal
compianto dottor Giuseppe Aragona nel suo pregevolissimo volume su
Cerenzia pubblicato nel 1989 e ristampato recentemente.
Torna all'inizio
Torna all'inizio
Torna all'inizio
Torna all'inizio
Torna all'inizio
Evemtualmente...?
Torna all'inizio