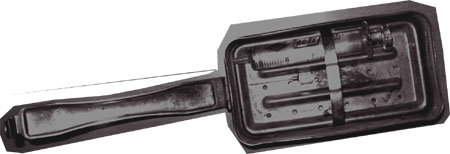| Quello
che non c'è più |
|
Qualche settimana fa ho finito di leggere un bel libro del grande Francesco Guccini dal significativo titolo di Dizionario delle cose perdute. Si tratta di una intelligente rivisitazione nostalgica del proprio vissuto alla ricerca di oggetti, situazioni, stili di vita che abbiamo perduto per sempre, un patrimonio immenso cancellato dalla tecnologia e dalla modernità, ma che spesso non riusciamo o non vogliamo rimuovere definitivamente, almeno dalla nostra memoria per non rimuovere la nostra stessa vita e che ricordiamo sempre con struggene nostalgia. Inoltrandomi sempre più tra le pagine dello scrittore e cantautore modenese riaffioravano alla mia mente una infinità di attrezzi, oggetti, usi, riti, sistemi di misurazione, perfino angoli suggestivi del nostro paese che non esistono più e che ritengo valga la pena di riesumare, alla stregua dell'autore de "L'avvelenata", magari con l'aiuto di qualche amico che potrebbe inviarmi qualche utile suggerimento. Proviamo.
Affàscinu
C'è ancora qualcuno che crede nell' "affascinu" o che teme di essere affascinatu? Questa parola pare derivi dalla lingua catalana (fascinar) e abbia il significato di ammaliare. Gli spagnoli non si limitarono a imporci il loro malgoverno; ci "regalarono" anche le loro superstizioni che si aggiunsero a quelle, non poche, di origine greca o magno greca. Fino a un cinquantina di anni fa la stragrande maggioranza della popolazione locale credeva ancora che si potesse gettare il malocchio su qualcuno anche involontariamente, non solo con intenzionalità. Bastava, ad esempio, gioire della fortuna o del successo di qualcuno per "affascinarlo" per cui succedeva a volte che anche un complimento, una compartecipazione sincera a una gioia finiva per procurarti un'antipatia (se non una inimicizia) da parte della persona lodata perché, appena gli capitava un piccolo fastidio attribuiva la colpa al malocchio che gli avevi gettato addosso gioiendo della sua precedente fortuna. A quel punto la "vittima" del malocchio, ritenendo di essere stata probabilmente affascinata, si rivolgeva a una delle decine di esperte disseminate per il paese che, al pari di quelle che " jìanu cu' li morti " (eccone una di origine greca) ossia le indovine che conocevano il futuro grazie al fatto che bazzicavano i morti che glielo rivelavano, erano sempre pronte a dare una mano al prossimo. Ovviamente per spascinare, cioè togliere il malocchio, bisognava prima accertarsi che la persona fosse stata colpita davvero dal malocchio, ma questa era una pura formalità quasi sempre inutile, dal momento che il cento per cento dei "pazienti" risultava sempre affascinatu. Quando ci si rivogeva all'esperta per essere spascinati, la megera chiedeva un fazzoleto pulito o un altro oggetto che apparteneva all'interessato e lo deponeva sul grembo. Poi iniziava a biascicare parole incomprensibili e si metteva ad "alare", cioè a sbadigliare in modo appariscente. Questa era la prova inoppugnabile che la persona che aveva di fronte era stata affascinata anche perchè, per un motivo che nessuno è mai riuscito a spiegare in modo convincente, quando vediamo una persona sbadigliare veniamo coinvolti anche noi e ci mettiamo a imitarla. Anche le vittime dell'affascino non sfuggivano a questa regola e sbadigliavano insieme alla maga che aveva gioco facile a convincerle di essere state effettivamente affascinate. Poi, finalmente, poneva fine alla commedia rassicurando il gonzo di turno della perfetta riuscita dell'operazione ricevendo come compenso un piccolo dono o , nella peggiore dell'ipotesi, la gratitudine e la soggezione del beneficiato. Intanto così alimentavano antipatie e inimicizia nei confronti degli ignari jettatori. Oggi sembrerebbe che l'affascinu sia sparito, almeno come lo concepivamo una volta e, con esso, anche le "spascinatrici." Però, dite la verità: superstizione o non superstizione, questi personaggi pittoreschi non ci mancano un po'?
' A luce a gas (lampada ad acetilene)
Prima del 1957 quando non era ancora arrivata la "luce della SME", Caccuri era servita dalla Società del Lese ('a luce 'e Lesa) che produceva energia idroelettrica sfruttando una piccola condotta forzata con l'acqua di quel fiume. Il cuore della centrale era un alternatore poco più grande di quello di un moderno autocarro. Nei primi anni l'energia prodotta era sufficiente ad alimentare i paesi della zona, poi, con l'aumento di consumi, la tensione si era notevolmente ridotta tanto che nelle case la luce delle lampadine si era ridotta a poco piu di quella prodotta da una brace. La gente allora si ingegnava come poteva. Le famiglia più povere ricorrevano alla "luce a r'ogliu", una lampada ottenuta riempiendo a metà un bicchiere di acqua sulla quale si versava qualche cucchiaio di olio. L'olio, dopo qualche minuto, si depositava sulla superfice dell'acqua e allora le nostre mamme collocavano sul liquido giallo lo stoppino di cotone idrofilo che, una volta acceso, forniva una luce fioca consumando lentamente lo strato di olio. Altre famiglie utilizzavano steariche, altre ancora l'efficientissima lampada ad acetilene, inventata nel 1900, che utilizzava appunto l'acetiene, un gas che si otteneva immergendo in un po' d'acqua un pezzetto di caburo di calcio. Questa lampada forniva molta più luce degli altri mezzi, ma andava maneggiata da esperti per evitare pericolosi incidenti. L'acetilene, infatti, manipolato in modo imprudente, poteva provocare guai seri. Ne sapeva qualcosa il giovane Giuseppe Lacaria, comunista, antifascista caccurese morto in esilio in Belgio che da bambino si era rovinato una mano rimanendo invalido per il resto dei suoi giorni, proprio con gioco del "cannatellu." Per questo pericolosissimo gioco si adoperava un barattolo di latta (cannatellu) che aveva contenuto del concentrato di pomodoro o tonno al quale si praticava con un chiodo un forellino sul fondo e lo si capovolgeva su di una buca dello stesso diametro scavata nel terreno e riempita di acqua nella quale si gettava una pietruzza di caburro. Poi con una canna alla quale era stato collocato in punta uno stoppino acceso, si cercava da lontano il buchino dal quale fuoriusciva il gas che si infiammava e scoppiava. A quel punto il barattolo partiva come un razzo verso il cielo per ricadere dopo qualche secondo, spesso sulla zucca dell'improvvisato artigliere. Questo se era stato collocato perfettamente orizzontale rispetto al terreno. Quando invece risultava leggermente inclinato o magari si inclinava mentre si tentava di fare scoppiare la mina, partiva a volo radente rischiando di provocare guai seri.
Asino
" Avia 'nu sceccarellu c'era 'na cosa fina, si la facìa ragliannu da' sira alla matina" cantava una delle più famose canzoni popolari calabresi quanno ancora 'u ciucciu era il compagno più fidato, più inseparabile, più amato dai nostri contadini, uno dei "pilastri" fondamentali della società contadina. Non c'era un solo contadino che non avesse il suo bel somarello che lo aiutava in tutti i suoi lavori contribuendo in maniera determinante ai bisogni della famiglia. Poi arrivarino l'Ape Piaggio, i Fiorini ed altri mezzi moderni di trasporto, si chiusero le stalle sostituendole con il box e i ciucci sparirono dalle nostre contrade. Gùmmulu
Chi
ricorda o meglio chi usa ancora il vecchio caro gùmmulu?
Eppure era uno degli oggetti più usati nelle nosre case,
soprattutto d'estate quando la calura trasformava l'acqua da bere in
brodo caldo e non c'era ancora il frigorifero a refrigerare le nosre
bibite. Allora era il nostro prezioso, caro gùmmulu
a compiere questo prodigio. Si, perchè trattandosi di un recipiente
poroso, lasciava trasudare l'acqua che, evaporando, sottraeva calore
al contenitore raffreddandolo e mantenendo il liquido relativamente
freddo. Ciavule (taccola, corvus monedula) "Che
fine hanno fatto 'e
ciavule?" è la domanda che ci
poniamo in molti dopo la scomparsa di questi socievoli animali
che fino agli inizi degli anni '90 vivevano nei
fori per impalcatura (grupi 'e nnàita)
del castello, nonostante la caccia spietata che gli davano i ragazzi
con le loro frecce (fionde)
da non confondere con l'arco (freccia
a spizzìnguli dove 'u
spizzìngulu era appunto la freccia).
Ogni anno, nel periodo della nidificazione, quando nascevano i
piccoli, decine e decine di ragazzi stazionavano nella villa
comunale, ai piedi del castello sul lato nord e con le loro fionde
tenevano lontane le madri che cercavano disperatamente di portare
cibo ai figlioletti. Quando i piccoli, affamati si affacciavano dal
foro in cerca della loro madre che tardava, spesso cadevano di sotto
ed erano facile preda dei monelli, altre volte venivano colpiti
dalle pietre scagliate dalla fionde finendo comunque a terra.
Allora, purtroppo, erano altri tempi e non c'erano ancora o
perlomeno non operavano nella nostra zona le associazioni per la
protezione degli animali come la Lipu per cui nessuno si premurava
di far finire quel gioco crudele. D'altra parte anche adesso,
nonostante siano state approvate diverse leggi per proteggere gli
animali, non si riesce ancora a vincere la battaglia contro la
caccia. "Bisogna
pazientà fino ar momento che quarche legge nun distinguerà chi ce
fucila pe' necessità da chi ci ammazza pe' divertimento"
scriveva Trilussa,
ma quel momento non è ancora arrivato. Comunque, nonostante quella
spietata, barbara usanza, le ciavule
non hano mai
abbandonato il nostro paese; lo hanno fatto invece, stranamente,
quando quella stupida caccia era cessata da oltre vent'anni. Chissà
perchè? Chioccia (Jocca )
" Me para ca se vo' parare jocca" esclamava mia madre quando una gallina, col suo comporamento insolito, manifestava il suo "desiderio di maternità". Allora la mamma si affrettava a prepararle il nido contenente un discreto numero di uova che la chioccia si affrettava pazientemente a covare. Allora anche per noi bambini iniziava un'attesa impaziente che durava fino a quando le uova non cominiciavano a schiudersi e i pulcini completavano l'opera liberandosi compleamene dal guscio. Qualche volta capitava che fra le uova ve ne fosse uno "cuvatusu" cioè non fecondato dallo sperma del gallo, destinato fatalmente a marcire sotto la chioccia per cui dovevamo sorbirci il suo pestilenziale odore. Ogni volta che la chioccia si prendeva una breve pausa allontanandosi per qualche attimo dal nido correvamo a esaminare attentamente le uova nella speranza di scorgere qualche segno di vita. Poi, quando la chioccia e la covata si mettevano in moto razzolando nel cortile, la seguivamo a prudente distanza perchè la chioccia, temendo che volessimo far male ai piccoli, centuplicava la sua aggressività. Oggi anche da noi è difficile trovare qualcuno che allevi ancora galline e chi lo fa le compra già quasi adulte, di quelle nate nelle incubatrici. Insomma una sorta di fecondazione assisita. Per le galline non si applica la legge 40 e la chiesa non è contraria alla riproduzione dei polli con metodi artificiali. Almeno per ora. Addio vecchia, nevrotica, amata jocca! E'
fragule Funci mucchjiaruli
Da bambino seguivo spesso nonno Saverio che andava in cerca, sulle colline che circondano il paese, di un particolare fungo chiamato "funciu mucchjiarulu," ma che col tempo ho imparato a chiamare lattarico o, per essere più precisi, lactarius tesquorum. Da bambino odiavo questo particolare fungo, dal sapore amarissimo, che la mamma mi presentava sulla tavola e che cercavo in tutti i modi di evitare, poi, pian piano, ho cominciato ad apprezzarlo, specialmente se lo si faceva arrosto e vi si versava sopra un filo d'olio. Allora il sapore forte si combinava con il profumo dell'olio e il risultato era un piatto davvero eccezionale. 'U mucchjiarulu era un "fungo dei poveri" che cresceva nelle terre povere, aride, terre ricoperte da grandi cespugli di cisto (mucchji), soprattutto sulla Serra del Cucco o alla Guardiola. L'ultima volta che ho visto raccogliere i mucchjiaruli fu verso la metà degli anni '80 quando un gruppo di baresi facevano un blitz settimanale proprio nella zona della Guardiola per riempire il bagagliaio dell'auto di questi funghi che, dicevano di vendere a industrie farmaceutiche che li adoperavano per particolari prodotti galenici. Non so se all'epoca mi dissero la verità, né so se ancora si trovano e se qualcuno li raccoglie, anche perchè molti li ritengono tossici, ma mi sa che il prossimo autunno torno a cercali come facevo da ragazzo. Magarìa
Un'altra delle cose che ci manca e di cui nessuno si ricorda più è la magarìa, ovvero la fattura, che non è quella cosa che provoca una tremenda allergia a certi professionisti, meccanici, carrozzieri, idraulici, ma una diabolica macchinazione delle megere locali ai danni di qualche persona a loro invisa. Precisiamo subito che la magarìa era un po' diversa dalla tradizionale fattura, ovvero dall' offerta di un oggetto a Satana affinché vi imprimesse la sua forza malefica. No, le nostre fattucchiere (che poi erano donne innocenti spesso ignare delle maldicenze ai loro danni), si limitavavano, secondo le loro accusatrici, a infilare in qualche buco (generalmente grupi 'e nnaita, cioè quei fori che venivano lasciati nella muratura a pietra per consentire il montaggio delle impalcature in legno) una ciocca di capelli mischiata a qualche altra cianfrusaglia che, sempre secondo le accusatrici, poteva far ammalare gravemente la persona presa di mira, farla disamorare o innamorare follemente di qualcuno e cose del genere. A volte le "inquisitrici" fingevano di mettersi alla ricerca spasmodica del diabolico maleficio fino a capitare, così, giusto per caso, davanti al buco che conoscevano benisismo per averci infilato loro stesse la fattura che estraevano trionfalmente come prova inoppugnabile della macchinazione dell'ignara fattucchiera presa di mira e additata al pubblico disprezzo. A questo punto aggiungiamo che un'altra cosa che ci manca e che rimpiangiamo davvero è la penna del grande Eduardo; chissà che belle commedie avremmo potuto scriverci su queste superstizioni e beghe tra comari. Raccolta
differenziata porta a porta di un tempo che fu
Mi
viene da ridere (o da piangere, fate voi) sentendo ogni volta
qualcuno che ci parla delle mirabilia della raccolta differenziata
porta a porta, che tutti magnificano , ma che poi non si
riesce mai a fare, come se fosse una invenzione moderna come l'IPad,
il Tablet o qualche altra diavoleria tecnologica. Invece la raccolta
differenziata porta a porta ha origini antichissime ed era un
qualcosa che si faceva senza proclami roboanti, senza
schiamazzi e senza trionfalismi fino agli inizi degli anni '60.
Erano quelli tempi nei quali non si buttava niente, c'era una forte
coscienza ecologica e una radicata cultura del riciclo; poi
l'esplosione del consumismo, favorita dalla neonata televisione di
stato e da quella detta commerciale, mise fine a questa
consuetudine e diede inizio ad un imbarbarimento della società
contrabbandato per progresso e modernità. Uno dei motivi per i quali da fanciulli aspettavamo con trepidante ansia il ferragosto era l'arrivo " 'e re bancarelle", le bancarelle dei negozianti di giocattoli allestite nel tratto tra l'inizio dei Mergoli e quello di via Misericordia subito dopo piazza Umberto (la vera piazza Umberto, non quella ancora senza nome che ci ostiniamo, forse per vergogna, a chiamare piazza Umberto). C'erano si altre attrattive, come ad esempio il mitico tiro a segno di don Serafino con il bersaglio che quando lo colpivi cadeva lungo una guida di ferro su una piccola carica di polvere che esplodeva provocando un simpatico botto o con i fucili a piumini (piccola freccetta che terminava con un fiocchetto colorato) uno dei quai una volta, partito dal fucile di un giovane maldestro, si conficcò nello zigomo del vecchio giostraio facendolo bestemmiare per il dolore, ma quelle erano attrattive per quelli più grandi, mentre noi bambini ci accontentavamo della pistola ad acqua, dello stantuffo o della sampugnella. 'A sampugnella era una specie di corista a fiato a una sola nota collegato a un normalissimo palloncino di quelli che si usano per riempirli di elio e farli librare in cielo. Il divertimento consisteva nel soffiare nel corista per gonfiare più che si poteva il palloncino, quindi si lasciava che lo stesso si sgonfiasse. L'aria uscendo faceva vibrare la laminetta del corista che emetteva una nota lunghissima e monotona. Come passatempo non era il massimo e forse anche un tantino noioso, ma per la nostra generazione, che non conosceva la play station e le altre diavolerie, era il massimo dello spasso. Per dovere di cronaca c'è da dire però, che nell'attesa del ferragosto e delle sampugnelle, avevamo scoperto (o meglio lo avevano scoperto i nostri nonni e forse prima di loro i nonni dei nonni) una sorta di surrogato delll'agognato strumento utlizzando "i cannoli" cioè gli scapi fiorali delle cipolle che andavano in semenza. Soffiandovi dentro con particolari accorgimenti se ne ricavava un suono simile allo squillo di una tromba. Siringa riutilizzabile
'U scaru Fino alla fine degli anni '40 dello scorso secolo, nonostante le secolari battaglie dei contadini e dei braccianti senza terra, la quasi totalità dei terreni olivetati era nelle mani di pochi grandi proprietari terrieri. Ovviamente anche Caccuri non faceva eccezione per cui pochissime famiglie avevano la possibilità di farsi la provvista dell'olio, mentre la stragrande maggioranza doveva arrangiarsi come poteva. Molte massaie condivano i cibi con lo strutto che veniva conservato nella vesciga del maiale, altre si arrangiavano con lo "scaru." 'U scaru era un antichissimo jus, un diritto consuetudinario legato allo "'sbarru" cioè la facoltà di entrare in un uliveto o in un’altra qualsiasi tenuta agricola per raccogliere la residua parte di prodotto sfuggita al proprietario dopo che questi aveva terminato il raccolto. Ovviamente la quantità di prodotto che si riusciva a raccogliere era scarsissima, appena sufficiente a garantire una stentata sopravvivenza delle classi ultra popolari che vi si dedicavano. E, proprio per la miseria dei tempi, vi si dedicava tantissima gente fino ai primi ami '60 del Novecento. Oggi 'u scaru è scomparso e quasi tutti hanno in casa il loro bel recipiente con la provvista di purissimo olio extra vergine di oliva. Tacce Alzi
la mano chi ha meno di 50 anni e sa oggi cos'era una taccia. Eppure
fino a cinquant'anni fa ogni scarparu
(ciabattino) ne
aveva sempre una buona scorta. 'E
tacce erano
infatti i caratterisici chiodi corti a testa esagonale
grossa che si usavano per chiodare gli scarponi dei contadini
e spesso, anche quelle dei ragazzi, se non addirittura dei bambini.
Nella prima metà del Novecento le scarpe erano considerate un lusso
che molti non potevano nemmeno permettersi, figuriamoci se si poteva
correre il rischio di consumare le suole troppo in fretta. E così,
per scongiurare questo pericolo, le si foderava di chiodi e di trincilli
(lamine di ferro
che si applicavano sulla suola in punta),
tanto mica c'erano pavimeni in marmo o in ceramica che si potevano
rigare. I contadini poi usavano una speciale "crema
idratante" per la tomaia: 'u
sivu (sego
di maiale) per evitare che si rovinassero in fretta. Così trattate
le calzature non erano davvero profumate, ma a quell'odore si ci
faceva presto naso e diventava molto familiare. Trìpiru ( sostegno per pentole sul fuoco) Quando ancora il fuoco era ancora l'unico sistema per cuocere i cibi e si accendeva il fuoco anche d'estate appunto per cucinare, era indispensabile usare 'u trìpiru. Allora ancora non esistevano le cucine a gas. Ricordo come oggi quando compramo la prima cucina a gas fu un giorno di festa. Chiamarla cucina a gas è una esagerazione. Si trattava di un piccolo fornello a tre fuochi che, stranamente, si trova ancora in vendita che chiamavamo semplicemente "' u Gas", collegato a una bombola. 'U trìpiru (treppiede), era un sostegno circolare di diverse misure per le pentole, Aveva appunto "tre piedi" di ferro sormontati da un anello. I tre piedi appioggiavano sulla base del focolare e la pentola si poggiava sul sostegno circolare sotto il quale si accendeva il fuoco. Ancora se ne vede in giro qualcuno, ma diventano sempre più oggetti da museo. Vuoto a rendere Verso la fine degli anni '50 i miei gestivano un negozietto di alimentari e diversi. Ricordo come se fosse oggi i generi che si vendevano sfusi: il concentrato di pomodoro (uno due cucchiai per volta avvolti nella carta oleata), lo zucchero o la farina che "se 'ncoppavanu cu' la sassula" e si mettevano nei coni di carta fabbricati seduta stante dal negoziante con la carta da pasta o quella da zucchero, lo strutto avvolto anch'esso nella carta oleata etc. Perfino la varechina (ipoclorito di sodio) concentrata che, diluita nell'acqua formava quella che oggi chiamiamo candeggina, si vendeva sfusa, perfino il carburo per le lampade ad acetilene. Ma ricordo anche la fatica che si doveva fare per recuperare bottiglie di vino, di birra o di latte vuote che la gente comperava e che era tenuta a restituire per evitare noi si dovesse pagare al fornitore il vuoto mangiandoci il magro guadagno. Allora era sconveniente chiedere al cliente di depositare la cauzione perchè si rischiava di perderlo e poi, sia il pieno che il vuoto si compravano con la "libretta", quella che il mio amico Mario Morrone ha efficacemente definito "la carta di credito del tempo." Però è vero che si doveva faticare molto per recuperare il vetro, ma in compenso non si intasava la discarica di Vetrano. Oggi invece non c'è l'assillo di dover restituire il vuoto, però depositiamo, tre le altre porcherie, anche tonnellate di vetro nelle discaricche distruggendo l'ambiente e consumando quantità spaventose di energia per riprodurre le bottiglie. A proposito di Vetrano, sarebbe bello invitare tutti i sindaci della Calabria i cui comuni scaricano a Vetrano, tutti i sindaci che non fanno la raccolta differenziata e tutti i commissari straordinari per l'emergenza rifiuti che si sono succeduti in tutti questi anni, a trascorrere una settimana di vacanze a Zifarelli, Rittusa, Patia per respirare a pieni polmoni, magari al mattino presto, il dolci effluvi che promanano da quel salubre luogo.
Attenzione, la pagina è ancora in costruzione.
|