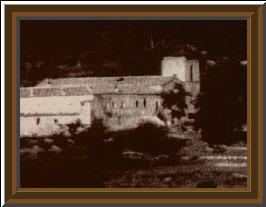|
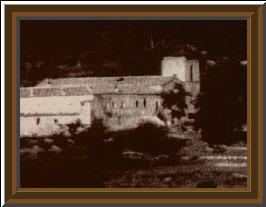 Il
convento nel 1924 Il
convento nel 1924
Il convento dei Dominicani di Caccuri venne edificato a partire dal 1515
nel luogo detto “il
Casale”, a circa due miglia di distanza dal vecchio monastero
basiliano dei Tre Fanciulli e a poche centinaia di metri dal paese, su
di un terreno che il sindaco del tempo e l’Università
misero a
disposizione di alcuni religiosi tra i quali frate Andrea da Gimigliano,
il vero e proprio artefice della fondazione di questo nuovo monastero
caccurese. Fra le altre cose il religioso del Catanzarese si recò anche
a Roma in San Giovanni in Laterano per ottenere le autorizzazioni
papali.
Tra
il monaco, le autorità e i cittadini di Caccuri ci si accordò per
erigere il fabbricato sull’area donata dalla stessa Università,
ovvero l’orto di un tal Filippo Piluso, già in passato appartenuto a
Gugliemo Sproveri. L’orto in questione confinava con la strada che
portava “all’ Aruso” (Laruso), un terreno a sud est della
cittadina, e la proprietà degli eredi del defunto Carlo Martino
(probabilmente S.
Andrea).
Reperito
il suolo, l’Università si impegnò a costruire a sue spese due
calcare (una fu inspiegabilmente demolita negli anni ’70) che
avrebbero prodotto la calce utilizzando la pietra calcarea della vicina
Serra Grande e concesse ai monaci di riscuotere una tassa di un tornese
per ogni rotolo di carne o pesce che si vendeva in paese per ricavarne
le somme necessarie alla costruzione dell’edificio. Le autorizzazioni
ecclesiastiche furono concesse da Papa Leone X°. Poterono così
iniziare ufficialmente i lavori (che erano in effetti già iniziati) per
la costruzione dell’imponente complesso monastico con la benedizione
del vescovo dell’epoca Gaspare de Murgis.
Nel
1542 l’abate Salvatore Rota, commendatario del vicino
monastero dei Tre Fanciulli (Patia) donò alla chiesa annessa al
convento la statua di S. Maria del Soccorso. La vita monastica nel nuovo
cenobio procedette tranquilla per tutto il XVI° secolo, anche se i
frati non riuscirono mai a reperire i fondi necessari per completare la
costruzione. I monaci coltivavano i terreni intorno al monastero
attingendo l’acqua dal vicino ruscello di San Nicola che alimentava la
vasca di irrigazione (‘a cipia e ri monaci) nei pressi del campanile. L’acqua
potabile giungeva invece da Sant’Andrea ed il convento era immerso nel
verde. Tutto ciò rendeva il luogo ameno e adatto al
raccoglimento al punto che il vescovo di Cerenzia mons. Maurizio Ricci
nel 1626 volle trascorrervi gli ultimi giorni della sua vita proprio nel
convento caccurese e fu sempre particolarmente legato a questo luogo di
preghiera e di raccoglimento a pochi chilometri di distanza dalla sua
diocesi. All’epoca vivevano nel monastero undici religiosi, tra
sacerdoti, monaci e professi, ma già qualche decennio dopo il numero
dei frati si ridusse a meno di sei, tanto che, come prevedeva la
costituzione di Innocenzo X, se ne decise, in data 24 ottobre del 1652,
la chiusura.
A
contribuire a questa drastica decisione fu anche la grave situazione
finanziaria dovuta al fatto che molti dei terreni di proprietà non
erano fittati perché i cittadini di Caccuri, che avevano dovuto
affrontare le spese per riparare i danni del terremoto del 1638, non
erano in condizioni di poter assumersi altre spese, i tre mulini erano
diroccati e, nelle ultime tre annate, c’era stata una spaventosa
carestia.
Due
anni dopo, però, nel 1654, il convento riaprì i battenti e, nel secolo
successivo, riacquistò la sua autonomia. All’epoca i frati che vi
abitavano erano ben 12 e, anche grazie alla munificenza dei Cavalcanti,
la chiesa si arricchiva sempre più di opere d’arte. Il
convento aveva diritti su circa cento ettari di terreno, possedeva
diverse vigne, case, armenti e 13 maiali. Fu in questo periodo,
probabilmente, che qualche bontempone coniò la famosa espressione nota
ad ogni caccurese, “dodici monaci, tredici porci”, a significare che
i religiosi non se la passavano poi troppo male e che tutti i giorni
mangiavano “cuzzettu e fave”, ossia guanciale bollito con le fave.
Nel
1690 il Padre Provinciale dei Predicatori concesse l’autorizzazione ad
erigere, in una stanza del convento, la cappella della Congregazione del
Santissimo Rosario accogliendo una richiesta di un gruppo di cittadini
caccuresi tra i quali Francesco Bonaccio, Orazio Antonio Novello,
Filippo Mele, Santino Falbo e Francesco Mele. Come contropartita il
Padre Provinciale pretese dalla Congregazione il versamento della somma
di 15 carlini annui al convento a titolo di elemosina.
Ottenuta
l’autorizzazione i confratelli si misero subito all’opera e, grazie
anche alla munificenza dei Cavalcanti, la chiesetta si arricchì sempre
più di capolavori dell’arte barocca, sculture e quadri.
Particolarmente sensibile e generoso si mostrò don Antonio Cavalcanti,
figlio primogenito del duca Don Marzio che rinunciò alla successione
per farsi cavaliere di Malta e che convinse il padre a donare
alla Congregazione, con un atto del 4 gennaio 1750 stilato nel castello
di Caccuri e controfirmato dal suo segretario Diego Guarascio, che era
anche il sindaco dell’epoca, il ricco terreno denominato Vignali a est
della cittadina. Ciò gli valse una epigrafe in latino che è possibile
ancora leggere sugli scanni corali della chiesetta e che ci informa che
“tutto ciò che si vede nel tempietto fu condotto a termine dal frate
dominicano Antonio Cavalcanti, nell’Anno del Signore 1753, in voto
alla Vergine del Rosario perché la si possa lodare.”
Nel
1824 la Congregazione implorò il Papa affinché concedesse
l’indulgenza plenaria per coloro i quali visitavano la chiesa nei
giorni delle feste principali e in tutte le domeniche dell’anno. I
confratelli chiedevano inoltre che questo privilegio fosse perpetuo ed
applicabile “pur in suffragio delle anime del Purgatorio”.
Il
Papa Leone XII, il 24 luglio dello stesso anno, su sollecitazione del
cardinale Nava, concesse il privilegio. Infine, qualche anno
dopo, i confratelli chiesero al Santo Padre di “voler loro
accordare la partecipazione ai privilegi che si godono dall’ordine dei
Predicatori, quantunque vengano diretti nello spirituale dai Religiosi
riformati, venendo raccomandati dal proprio ordinario coll’attestato
che si umilia qui annesso.”
Anche
quest’ultimo privilegio venne concesso dal papa Gregorio XVI° il 27
marzo del 1835. I nomi dei confratelli trapassati, dal 1835 al 1860, venivano
annotati in un registro conservato nella stessa chiesa. Il lunedì di
Carnevale, poi, sempre nella stessa chiesetta, veniva celebrata una
messa in loro suffragio con la presenza sull’altare dei teschi di
alcuni defunti tra i quali quello dello stesso fondatore Antonio
Cavalcanti. Questa singolare tradizione rimase in vigore fino alla metà
degli anni ’50 quando la Congregazione fu sciolta.
La
piccola, splendida chiesa è adornata da un altare barocco con tela
raffigurante la Vergine del Rosario e S. Domenico inginocchiato ai suoi
piedi nell’atto di ricevere dal Bambinello, che è in braccio a Maria,
il rosario. Si tratta di una rappresentazione unica nel suo genere in
quanto non vi è raffigurata, a differenza di molte altre tele simili,
S. Caterina. Ai lati dell’altare, in due nicchie, sono custodite le
statue dell’Addolorata e della Madonna dei Fratelli. Sulla volta sono
rappresentate scene del vecchio testamento. All’interno degli scanni
corali, come è già stato detto, vengono custoditi i teschi dei
confratelli defunti recuperati agli inizi del XIX secolo dalle fossae
mortuorum.
Tornando
alla Chiesa della Riforma, va ricordato che nel 1781, Francesco Paolo
Cristiano decorò il monumentale altare di San Domenico.
Qualche
anno dopo, nel 1809, quando i Francesi occuparono il Regno di Napoli, il
convento dei Dominicani venne soppresso con un decreto del 7 luglio.
Riaprì solo nel 1833 per iniziativa dei frati Francescani Riformati che
vi rimasero fin dopo l’Unità d’Italia quando fu soppresso
definitivamente. Nel 1865 monastero e chiesa furono venduti al barone
Giovanni Barracco e, nei primi anni ’50, gli eredi Barracco rivendettero
il monastero a privati, mentre la chiesa divenne proprietà
della curia arcivescovile.
Nel
1956 furono eseguiti alcuni lavori fra i quali la copertura del
campanile ed il rifacimento del tetto. Nel piano terra del campanile era
stata ricavata una stanza nella quale abitava un vecchio muto e la
moglie che custodivano e pulivano la chiesa. A quei tempi vi
era ancora abbondanza di opere d’arte e di arredi tra i quali un
grande organo a canne che, pare, venne poi venduto verso la fine del
decennio perché oramai inservibile. Probabilmente in
quell’occasione fu demolito e disperso anche il soppalco che
sovrastava l’ingresso del tempio e che era retto da colonne in legno.
Su una di esse era stata collocata una cassetta delle elemosine con
scolpito un bassorilievo della Morte e la scritta “Come tu sei io fui;
come io sono tu sarai.”
Negli
anni ’60 e ’70 il degrado del monumento subì un’accelerazione
finché, nel 1972, crollò il tetto e la chiesa rimase scoperchiata per
otto anni. Negli anni ’80 l’amministrazione del tempo provvide, con
fondi propri e con contribuiti della Provincia e della Regione, ad
eseguire alcuni interventi urgenti che impedirono la perdita definitiva
del bene. Attualmente sono in corso lavori per impedirne l’ulteriore
degrado della importante chiesa.
Tra
le opere più significative di quelle che si sono salvate e sono giunte
fino a noi nonostante l’incuria, l’abbandono e gli sfregi arrecati
al monumento, figura un bellissimo ambone intagliato, un crocifisso
ligneo, le statue di San Vincenzo, Sant’Antonio e San Francesco di
Paola e quella della Madonna del Rosario.

|